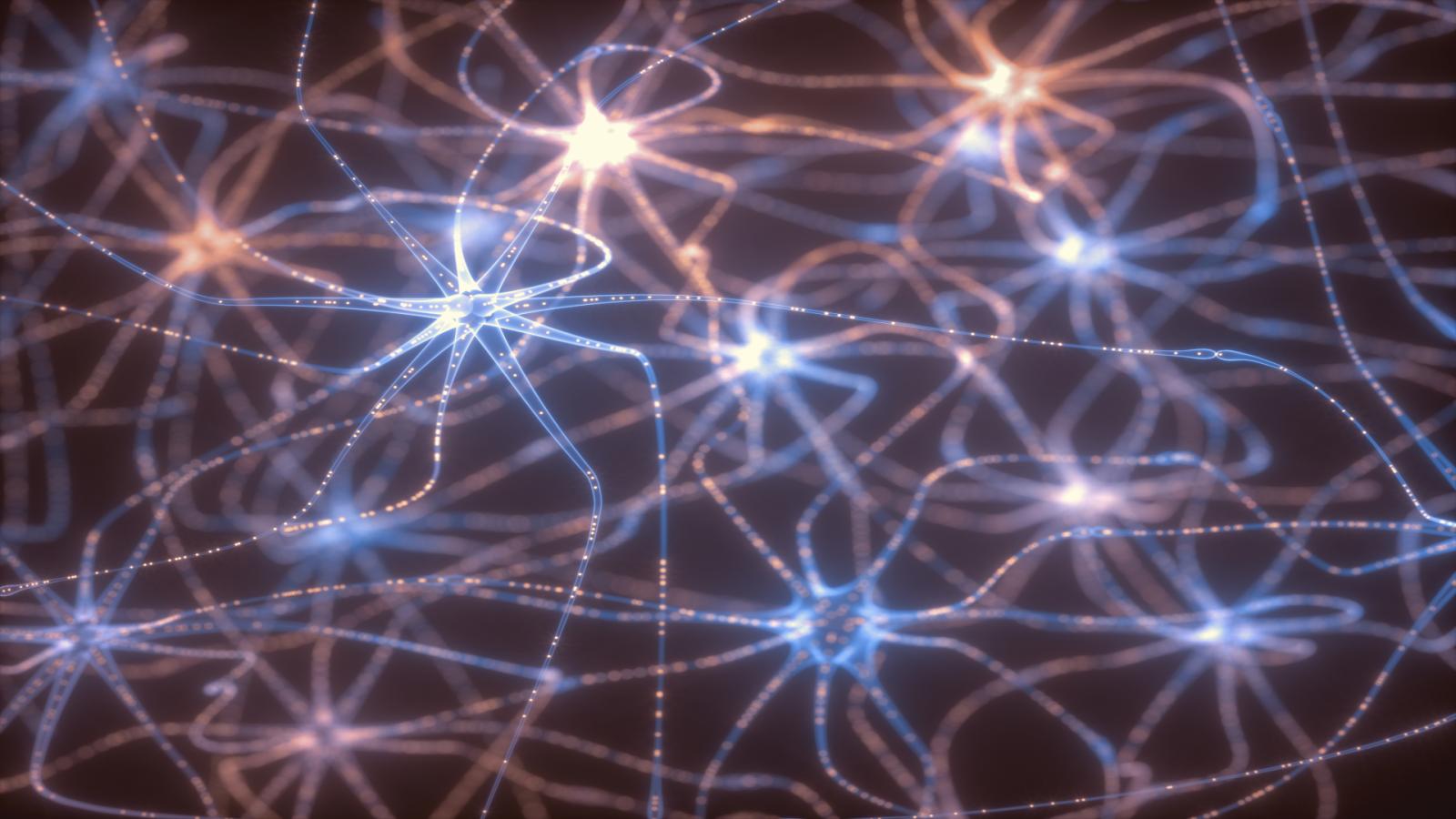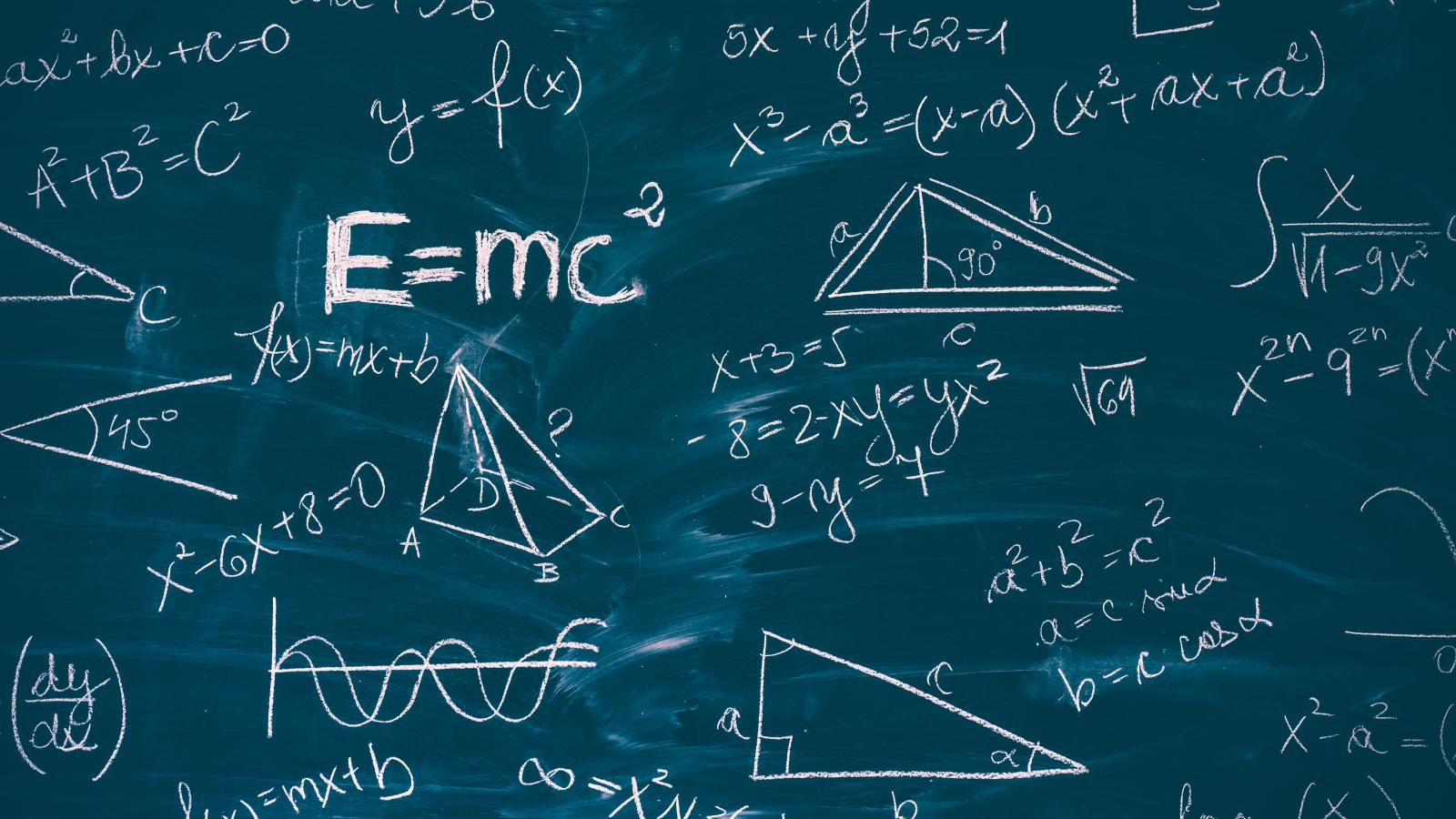Una dilaniante nostalgia di futuro

Ammettiamolo, siamo preda di una dilaniante nostalgia di futuro. Futuro perché la narrazione tecnologica che abitiamo è geneticamente accelerazionista
Dal punto di vista del mercato è una sorta di grande mattina di Natale: lascia costantemente intravedere un regalo da scartare, un viaggio da prenotare, un oggetto da ritirare, un like o anche solo una view da ottenere. Domani, stasera, oggi, dietro l’angolo (con eventuale balenante fear of missing out).
Il futuro è già qui anche sul versante etico-politico. L’eccitazione per l’IA o l’ibridazione uomo-macchina sono puro futuro, così come la delega dei lavori usuranti ai robot, la responsabilità planetaria verde, l’idea del rispetto anche linguistico per le minoranze, l’attenzione servoassistita a cibo e benessere (l’app per tenere d’occhio gli zuccheri complessi, quella per il sonno, l’app per disintossicarsi dalle app), la presa in carico collettiva ed empatica dei bisogni psicologici individuali, la generale tensione verso temi da metafisica laica: meditazione, consapevolezza. L’era dell’Acquario.
Fin qui è tutto futuro, come vorremmo immaginarlo, costruirlo, abitarlo. E fin qui tutto bello ma con qualche brivido. E il brivido consiste precisamente nel fatto che il modello di futuro di cui stiamo parlando è fondato su un passato inattingibile, ed è quindi semplice nostalgia. A spiegare e testimoniare il concetto è bello convocare una popstar. La britannico-albanese Dua Lipa intitola il suo disco del 2020 “Future Nostalgia”. Racconta che vuole fare musica con le sonorità di domani e con quelle della sua infanzia: c’è il funk e c’è l’italodisco anni Ottanta, c’è l’autotune e ci sono i sintetizzatori analogici di ieri. C’è una nostalgia di futuro, o un futuro di nostalgia. Il disco ha raggiunto i trenta miliardi di stream. È solo la mania rappresentativa del vintage, della madeleine, dell’analogico nell’era digitale, una sorta di Proust ma ridotto a intenzione, che vorrebbe fare dell’avvenire un tempo ritrovato e che ci tenta le famose “nostalgie prenatali” come le chiamava Arbasino? È solo un fatto estetico o c’è qualcosa di più ampio e più profondo?

Qualcosa di più ampio c’è. Perché a dirla tutta questa nostalgia del futuro è una crepa nel fondamento della coscienza moderna. È l’anello che non tiene nella grande narrazione di miglioramento esistenziale, sociale, tecnologico, che ogni giorno ci raccontiamo tra piattaforme digitali, ambiente informativo, politica. È l’aspetto di Restaurazione, necessaria ma impossibile, nella nostra mitopoiesi progressiva. Paradosso suggerito dalla riflessione di Gilles Lipovetsky, che ha coniato il termine ipermoderno in un suo saggio del 2004, “Les temps hypermodernes”. Altri studiosi hanno parlato di società del rischio (Ulrich Beck), o di surmodernità (Marc Augé). Il significato è più o meno quello, la definizione di Lipovetsky è quella più intuitiva, più secca, più esatta.
In sintesi: l’antico crede nel passato, nella manifestazione originaria delle cose come ἀρχή, principio, nell’età dell’oro. Da quel momento in poi è stata tutta decadenza. La narrazione antica è essenzialista. La verità è certificata nel ritorno all’essenza immutabile delle cose. Dai dialoghi di Platone al messianesimo cristiano è tutto un tornare all’origine.
Il moderno crede nel futuro: l’umanità migliora sempre più, ad infinitum. La narrazione moderna è emancipativa, è storia della liberazione personale e collettiva dell’umanità. Tutto converge verso un futuro, un fine ultimo, una teleologia.
E qui arriva il problema. Possiamo davvero in questo spicchio di nuovo millennio credere in una teleologia? Possiamo ancora credere al moderno? Con tutto quello che abbiamo passato?
Inutile forse riepilogare vicende dolorosissime per l’Europa e per il mondo, gli scricchiolii rilevati dal vigile sismografo della primonovecentesca cultura della krisis, l’esplosione di conflitti bestiali su base ideologica, l’implosione di potenze che sull’ideologia del miglioramento avevano scommesso troppo, tutto, vedi alla voce URSS.
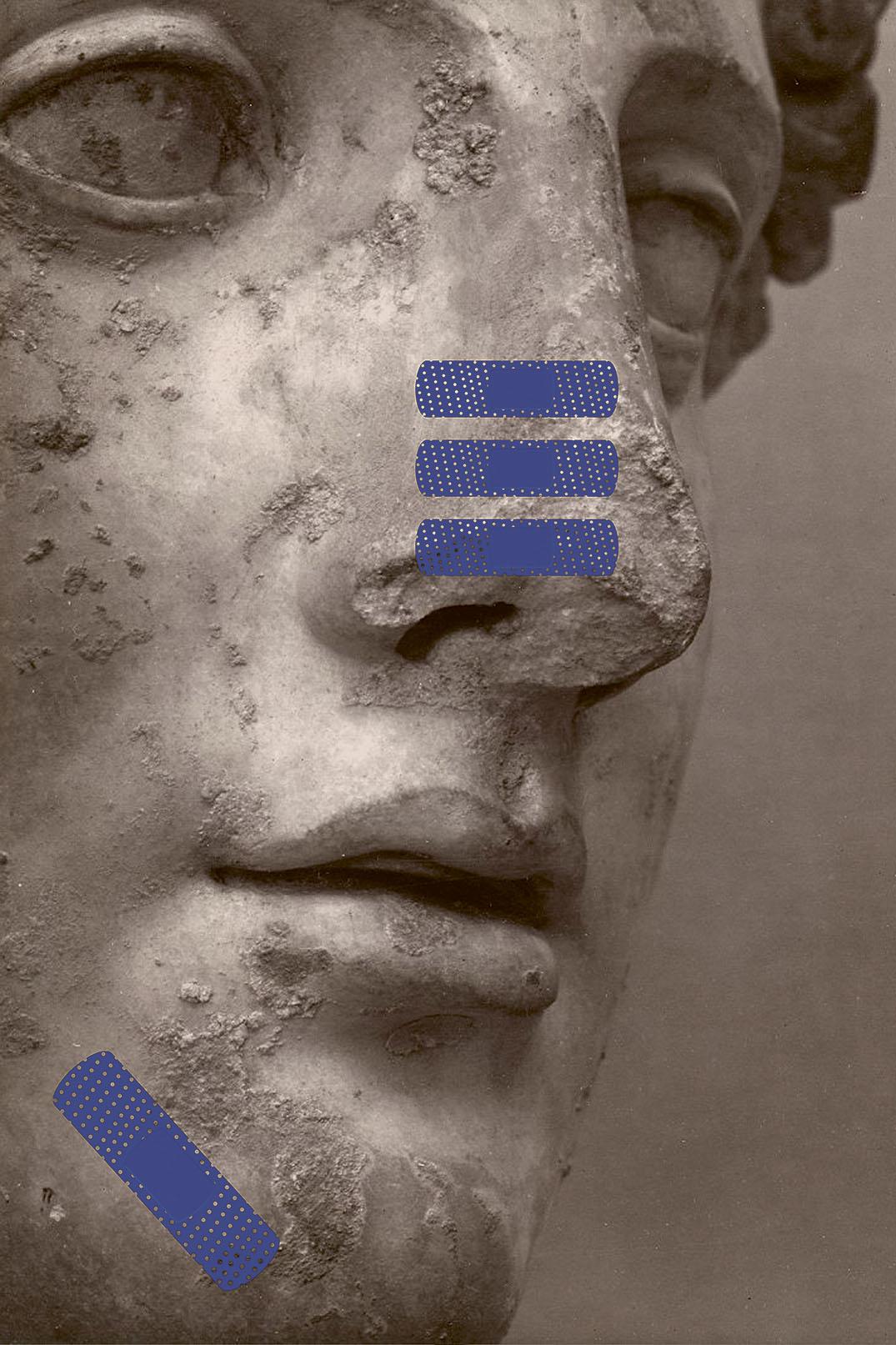
E si potrebbe aggiungere la tenuta molto imperfetta dell’idea di “civiltà occidentale” dentro alla quale, sì, viviamo e ci muoviamo, ma che al momento viene messa in dubbio da concorrenti che rimarcano nel bene e nel male (spesso nel male) la loro alterità rispetto a categorie che a noi, moderni e occidentali, sembravano incontestabili. Un accumulo di storie, fatti e conflitti che fanno sentire disillusi e pure stanchini. Forse ce n’è abbastanza per ammettere qualche scetticismo. Sulle grandi narrazioni e sulle filosofie della storia. Sul moderno.
Proprio questa disillusione è stata registrata e raccolta dal postmoderno. Germinato nel secondo dopoguerra, esploso con la pop culture, teorizzato nel 1979 con il breve, lucido e (troppo?) influente “La condition postmoderne” di Jean-François Lyotard, il postmoderno parte da un assunto semplice: le grandi narrazioni sono finite. Non si può più credere alla narrazione essenzialista degli antichi né a quella emancipativa dei moderni. Si sono rivelate entrambe mitologie consolatorie. Bisogna invece accogliere
pienamente il nichilismo. E raccogliere macerie di idee, ideali, ideologie, forme di rappresentazione antiche e moderne; bisogna giustapporle, farle collidere. Bisogna mostrarne i punti di frattura, le inadeguatezze, i deliri. Bisogna demistificarle. Il postmoderno lavora non con le presenze ma con le assenze di senso. Arriva a corteggiare le apocalissi e i cigni neri, usa l’horror e lo splatter, il kitsch e il camp. È ironico, freddo, anti-emotivo, non è per l’identificazione ma per la distanza. È una filosofia riflessiva, epistemologicamente generosa fino allo spreco: assume che il pensiero possa cogliere un guizzo di senso dall’esibizione del nonsenso.
Ma il problema vero è che il postmoderno è un modo di pensare costoso. Lavorare con tante forme di rappresentazioni, attraverso lo spreco e il nonsenso è divertente, euforizzante, intelligente, ma costa caro, in termini di conoscenza, ricerca, e in concreti termini monetari. È una filosofia da ricchi. E non rassicura affatto. Il postmoderno finisce quando l’Occidente sbatte il muso sul ritorno della Storia.
Tra gli anni Novanta e il nuovo millennio con la caduta del muro si assiste, lo sappiamo, all’irruzione della Storia, all’esplosione di conflitti nazionalistici nel cuore dell’Europa, a foschi riverberi ctonii che ci si illudeva fossero spenti. Con l’11 settembre 2001 si riparla di “scontro di civiltà” con un lessico e un’impalcatura ideologica che ricordano quelle della Reconquista mentre dall’altra parte riaffiora il lemma “crociati”. Più irruzione della Storia di così…
Dopo la crisi finanziaria del 2008, anche questa è cosa nota, aumenta il desiderio di rassicurazione. C’è bisogno, dice Lipovetsky, di un’idea post-religiosa di progresso. Si pensava che la storia fosse finita, ma dovendo stare nella storia è bene stare politicamente dalla parte giusta. E dal punto di vista esistenziale con la convinzione che scienza e tecnologia porteranno l’umanità verso un futuro migliore.
In breve: vengono riesumate le grandi narrazioni che sembravano seppellite, impossibili e sparite. Quella emancipativa che si identifica col miglioramento dell’umanità, stavolta legato alla tecnologia e ai diritti, e quella essenzialista legata all’identità della nazione, dei popoli, fino alla xenofobia. La prima è progressista, la seconda è conservatrice. La prima è di sinistra, la seconda è di destra. Il problema, come nota Massimo Recalcati in un bel libro lipovetskiano dal titolo “Le nuove melanconie. Destini del desiderio nel tempo ipermoderno” (Raffaello Cortina Editore, 2019), è che sono entrambe narrazioni fatte di identità artificiali. Recuperate. Simulacrali. Sentimentali.
Sono un futuro immaginato, ma fatto di nostalgia. Non è un caso che molte delle battaglie culturali in corso siano solo epigoniche di ideologie novecentesche e si riconfigurino su categorie già storicizzate e in buona parte inattuali. Una battaglia di nostalgie.
Il grande paradosso di un futuro nostalgico è tutto qui. Il filosofo Emilio Garroni scriveva: «non si torna all’innocenza non solo se ci si è scoperti colpevoli, ma neanche se ci si è scoperti innocenti». È necessario tornare all’innocenza (ovvero a credere alle grandi narrazioni) ma non possiamo tornarci pienamente per troppa disillusione. Da qui, spiega Lipovetsky, la dialettica di esaltazione e angoscia che caratterizza il nostro guardare al dopo. L’“iper” è proiettato nel futuro, il “moderno” guarda al passato. Ipermoderno.
Con tanta Future Nostalgia.
Leggi anche
Drone Contest, al via a Bologna la sfida di Leonardo per la prima volta al Dronitaly
Per la prima volta quest’anno il contest dell'azienda di difesa e sicurezza farà il suo esordio in pubblico, durante l’evento di riferimento per il mondo dei droni e dell’AI a Bologna
Quando la scienza imita la natura. Materiali ispirati al cervello per rivoluzionare i computer
I ricercatori di Texas A&M, Sandia Lab e Stanford hanno sviluppato una nuova tecnologia ispirata al cervello umano che permette di trasmettere segnali elettrici senza perdite e senza ripetitori, migliorando le prestazioni dei microchip e riducendo il consumo energetico
Ciclone Boris inonda l'Emilia-Romagna: cartografie dell’alluvione in tempo reale grazie a Copernicus EMS Rapid Mapping
Ancora una volta la regione padana affronta un'alluvione devastante, le mappe satellitari di Copernicus utilizzate per facilitare le operazioni di soccorso
4 (+1) esempi della teoria della relatività nella vita quotidiana
La teoria della relatività di Einstein ha rivoluzionato la scienza e influenza aspetti quotidiani come il GPS e la colorazione dell'oro, mostrando l'impatto delle sue intuizioni sulla nostra vita